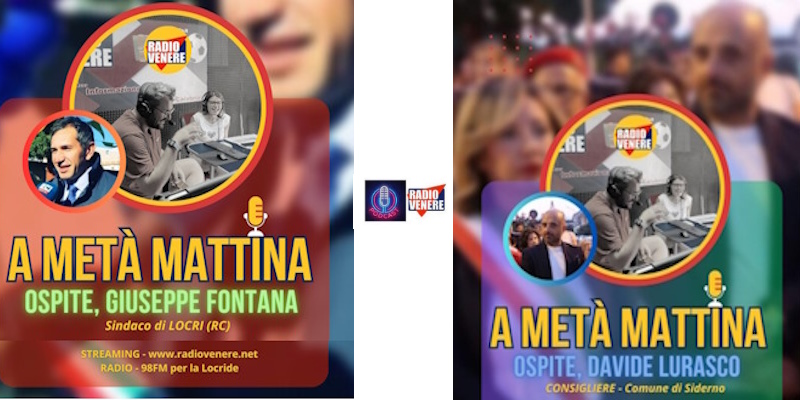Sentenza Viola: nessuna svolta epocale, soltanto un ritorno alla regola

La sentenza del 13 giugno 2019 [Viola c. Italia] emessa dalla I sez. della Corte Edu e la recente dichiarazione di inammissibilità del ricorso avanzato dal Governo italiano da parte della Grande Camera, che rende la prima – di fatto – definitiva ha portato alla ribalta il tema dell’ergastolo ‘ostativo’ che – dopo numerosi impulsi provenienti dall’avvocatura – è stato dichiarato incompatibile con i dettami costituzionali prima e con l’art. 3 della CEDU, poi.
Molti i dubbi intorno all’istituto in questione e ai riflessi che tale pronuncia avrà sulla vita dei condannati.
Ma cosa si intende per ergastolo ‘ostativo’?
Quando si parla di ergastolo ‘ostativo’ ci si riferisce al peculiare regime cui sono sottoposti i condannati all’ergastolo per uno dei gravi delitti elencati all’art. 4 bis O.P. [tra i quali figura quello di associazione per delinquere di tipo mafioso].
L’ostatività risiede - per questo tipo di condannati - nell’impossibilità di richiedere qualsivoglia beneficio premiale [permessi premio, liberazione condizionale, misure alternative alla detenzione] una volta scontato un certo quantitativo di pena e posto in essere un percorso rieducativo effettivamente proficuo e riabilitativo, salvo che – ai sensi dell’art. 58 ter O.P. – i condannati non collaborino con la giustizia [unico sbocco per sperare di riacquistare un giorno la propria libertà].
La sentenza Viola, dunque, non comporta alcuna svolta epocale e non favorisce – come molti vogliono far pensare – i ‘mafiosi’ ovvero i ‘terroristi’, ma soltanto si limita a ricondurre la normativa sui binari costituzionali.
E’ un ritorno alla regola - e questo va evidenziato con grande chiarezza – che [ri]attribuisce, al Magistrato di Sorveglianza [competente a decidere sulle richieste dei condannati], il potere di valutare caso per caso il percorso riabilitativo condotto da ciascun condannato. Sarà compito dello Stato, dunque, fornire prova dell’ effettivo recupero dell’ergastolano ovvero dimostrare che in capo a quest’ultimo persiste un quoziente di pericolosità sociale che non permette l’accesso ad alcun beneficio.
Dunque, secondo i dettami offerti dalla Corte EDU: ogni condannato deve poter domandare la liberazione, ma non per forza ottenerla laddove egli costituisca ancora un pericolo per la società.
Un ordinamento che non permetta la revisione della pena ‘perpetua’ de iure e de facto sottopone il condannato ad un trattamento inumano e degradante, ponendosi in assoluto contrasto con i diritti fondamentali dell’uomo, che caratterizzano ogni Stato di diritto.
Non si tratta di ‘garantismo estremo’ né di un attentato alla sicurezza nazionale, ma ogni Stato che affida alla pena non soltanto funzione retributiva, ma anche rieducativa ha l’obbligo giuridico di fornire a chiunque la speranza di ricominciare!
Avv. Giorgio Raffaele Loccisano